Le essenze speziate delle cose
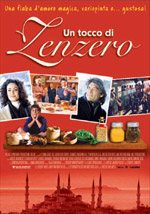
 Nella Turchia degli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta del Novecento, in un contesto mondiale in fibrillazione, il giovane protagonista del film vive in una realtà tutta sua.
Nella Turchia degli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta del Novecento, in un contesto mondiale in fibrillazione, il giovane protagonista del film vive in una realtà tutta sua.
Il bambino impara l’astronomia attraverso i sapori della cucina, cercando di cogliere l’essenza di ogni cosa (dei sapori e dei pianeti), e l’essenza, ogni volta, pare la stessa. La tesi del film, infatti, è questa: anche le cose apparentemente più distanti sono vicine. “Gastronomia” e “astronomia” hanno la stessa derivazione: a dirlo è il nonno, di origine greca come l’intera famiglia, come le due parole in questione, diventate simbolo di una filosofia.
Ciò non deve sembrare strano, il regista greco (greci sono anche i caratteri delle parole, nomi compresi, in testa e in coda al film), vuole offrire una sua visione del mondo.
Tale filosofia, semplicissima, di natura esistenzialista, trova un punto di equilibrio nell’uomo, che pone al centro.
L’uomo è misura di tutte le cose, dai sapori che decide di utilizzare nelle pietanze, ai pianeti a cui ha voluto conferire un carattere. Agli astri corrisponde infatti una divinità, e la divinità è metafora di aspetti fondamentali dell’uomo. L’uomo è il punto di incontro di mondi separati, che sembrano incommensurabili, e di questo è ben consapevole Immanuel Kant quando parla di cielo stellato sopra di noi e di legge morale dentro di noi. Il riferimento a Kant non è casuale: nel ritenere l’uomo misura di tutte le cose (come facevano i grandi sofisti) si scade nel relativismo, la posizione di chi sostiene che non esistano dati e valori oggettivi. Con Kant, venuto molti secoli dopo i sofisti, si fa un salto concettuale attribuendo solidità alle nostre conoscenze. L’uomo, infatti, lungi dall’essere di ostacolo a se stesso, contribuisce a creare il mondo di cui vuole cogliere l’essenza. L’essenza sta in lui, soprattutto per quanto riguarda la morale.
Ebbene, pur greco come i sofisti, il regista sembra più vicino a Kant, non pensa che tutto sia relativo, crede che esistano verità alla nostra portata.
L’uomo può cogliere l’essenza delle cose, ma riuscirci non è facile. Il nonno fa l’esempio del sale: esso non si vede, però uno sa che c’è. Da qui il suggerimento: cogliere sempre le essenze, ciò che gli altri non cercano, o non vogliono cercare, le cose invisibili, che pure rappresentano l’elemento determinante; senza il sale il pane non saprebbe di niente.
Il sale, soprattutto, rende simili cibi diversissimi tra loro, tutti ugualmente insipidi senza di esso.
Il posto del sale nella teoria kantiana ce l’ha l’intelletto, fattore trasversale che accomuna tutti gli uomini.  Un’analogia tutto sommato facile, che si incontra anche nell’uso quotidiano del linguaggio (“sale in zucca”). Sarebbe troppo facile concludere che l’intelletto andrebbe usato, esattamente come il sale; eppure, ad essere onesti, questa è una tentazione forte, vedendo il film: esso descrive molti eventi di stupidità umana, a partire dal conflitto greco-turco dei primi anni Settanta; di tale conflitto sono vittime il bambino e la sua famiglia. Infatti, greci residenti a Istanbul, vengono costretti a lasciare la città, che loro chiamano Costantinopoli. Perché poi non si sa: la città è sempre quella, la differenza è solo nominale, l’unica che la cultura può creare.
Un’analogia tutto sommato facile, che si incontra anche nell’uso quotidiano del linguaggio (“sale in zucca”). Sarebbe troppo facile concludere che l’intelletto andrebbe usato, esattamente come il sale; eppure, ad essere onesti, questa è una tentazione forte, vedendo il film: esso descrive molti eventi di stupidità umana, a partire dal conflitto greco-turco dei primi anni Settanta; di tale conflitto sono vittime il bambino e la sua famiglia. Infatti, greci residenti a Istanbul, vengono costretti a lasciare la città, che loro chiamano Costantinopoli. Perché poi non si sa: la città è sempre quella, la differenza è solo nominale, l’unica che la cultura può creare.
Nella scelta del nome c’è tutto il film, viene criticato un attaccamento alle origini lontane, poco rappresentative della vera essenza dell’uomo. Si tratta di fattori destinati a confondere la natura umana e non a coglierla, e i risultati sono alla fine negativi e, nel film, portano i protagonisti a ripensare tutta la propria storia. Che è piena di contraddizioni ben lontane dall’essere sciolte.
Basti pensare che il padre del bambino rimpiange Istanbul, salvo poi condannare la propria debolezza. Il prezzo per restare sarebbe stato troppo alto, e l’uomo solo a distanza di anni, nel distacco della memoria e dello spazio, riesce a parlarne – attorno ad un tavolo da pranzo – al figlio cresciuto e alla moglie. Per restare avrebbe dovuto abiurare la religione cristiana. E tale confessione sembra suscitare soltanto rammarico.
Nel film l’uomo parla chiaro, non si può perdonare di avere esitato un attimo, quando Istanbul gli era sembrata più importante della religione. Solo per un attimo, un attimo lunghissimo in cui era rimasto solo, l’uomo mise a dura prova la propria coscienza tentando di trovare una via di fuga dal rimorso e dal tempo – come se non fosse essa a produrre entrambi -, e i risultati si videro presto. La fuga – qualsiasi fuga – non era possibile, ma la scelta di abbandonare Costantinopoli era sembrata la più ragionevole.
La realtà però gioca brutti scherzi, e pare suggerire che la Contraddizione, rappresentata dalla scelta di abbandonare una città che si ama, sia la vera essenza dell’uomo, la sua natura.
Quale che sia la vera ragione, il rammarico del padre di aver abbandonato un posto per un altro getta comunque un’ombra sulla reale funzione della religione. Questa, in effetti, sembra ben lontana dal confortarlo, e la stessa incapacità presenta la patria d’origine: anche la Grecia, infatti, è stata ampiamente sopravvalutata al momento della scelta.
L’ammette senza mezzi termini il padre, poco campanilista quanto il regista, a cui i caratteri in greco in apertura e chiusura di film servono come provocazione.  Al di là delle differenze apparenti, occorre cogliere l’essenza comune. Nulla di più facile per le lingue, che anche quando si presentino in forme assai diverse, nel significato delle parole mostrano assonanze, vicinanze e uguaglianze.
Al di là delle differenze apparenti, occorre cogliere l’essenza comune. Nulla di più facile per le lingue, che anche quando si presentino in forme assai diverse, nel significato delle parole mostrano assonanze, vicinanze e uguaglianze.
Un’altra possibile interpretazione della scelta dei caratteri greci: il fatto che essi riportino alla lingua per eccellenza, quella che veicola tutti i concetti cardine dell’Occidente, a partire dall’“essenza”. Poi tale lingua si è persa, e con essa il popolo che la parlava, col risultato che anche i greci non riescono più a cogliere il vero senso delle cose.
La Grecia, quindi, rappresenta una meta ideale, non come luogo geografico ma come conquista dello spirito di cui è metafora.
A cura di
in sala ::