Il cerchio di sangue

 “Prima della pioggia” è un film segnato dal sangue. Sangue inteso in doppio significato: come traccia della guerra, della violenza, dell’odio; anche però come segno, al tempo stesso carnale e spirituale, della fratellanza, di un irriducibile vicinanza.
“Prima della pioggia” è un film segnato dal sangue. Sangue inteso in doppio significato: come traccia della guerra, della violenza, dell’odio; anche però come segno, al tempo stesso carnale e spirituale, della fratellanza, di un irriducibile vicinanza.
Manchevski ha dichiarato che per lui fare cinema non è fare arte, bensì trattare il mito. Nel mito è presente la memoria, da dove veniamo. Ricordo e memoria della morte, della sofferenza e di quella poca gioia. Il mito e tutta una serie di narrazioni, che unite (non in senso cronologico bensì seguendo la fratellanza, la vicinanza istintuale del racconto) fanno lacrimare la memoria, con lacrime di sangue. Perchè il mito è impregnato dal sangue: il sangue delle origini, della tradizione, del rito. Rito in cui si trova la memoria di un popolo, in questo caso il macedone, lacerato dal dolore.
La storia narrata dal cineasta è senza età, eterna: ferisce direttamente l’istinto; è anche però profondamente e visceralmente macedone e radicata negli anni, crudeli e amari, nei quali si svolge. Nel cerchio della vita e della morte della pellicola l’inizio è la fine e la fine è l’inizio, un eterno ritorno di strage e dolore. E quando tutto sarà finito, forse, resterà la memoria. Il regista è affascinato dal mito anche nel senso più avventuroso e romanzesco (ma non per questo meno nobile) del termine è profondamente influenzato dal cinema western;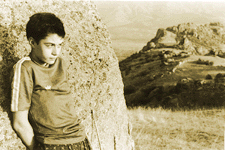 infatti nell’opera ci sono citazioni da “Il mucchio selvaggio” di Sam Peckinpah e da “Butch Cassidy” di George Roy Hill. Del primo, oltre alla sparatoria letteralmente esplosiva del capitolo “Volti”, prende una tortura di un animale: qui una tartaruga che agonizza nel cerchio (ancora…) della sofferenza e della memoria, lì degli scorpioni che mentre facevano strage di formiche vengono bruciati vivi da bambini sadici, divenuti dei pazzi e crudeli. La seconda, forse più gratuita, è la canzone fischiata in bicicletta dal protagonista che è la stessa sentita durante il corteggiamento, consapevolmente inutile di Paul Newman a Katharine Ross: in entambi i film è un momento sereno a cui però seguirà un epilogo tragico. Sembra che, basandoci anche su ciò che sappiamo di “Dust”, Manchevski abbia voluto creare nel suo paese natale una frontiera, un eastern. Non è un caso poi che entrambi i su citati western non siano delle celebrazioni della frontiera, ma rigurdino la sua fine, la sua scomparsa. In Peckinpah un epico urlo di odio contro tutto e tutti, in Hill una malinconica elegia. E questa frontiera a noi così vicina geograficamente e così lontana mentalmente, è ritratta sotto un segno barbarico e rituale. Viene alla mente il noir francese “I senza nome” di Jean Pierre Melville che in originale si chiamava “Le cercle rouge” (Il cerchio rosso): anche lì le vite sono unite in un cerchio di sangue e violenza voluto dal desino. Questo perchè, sembrano dirci quasi in coro due cineasti così irriducibilmente diversi come Manchevski e Melville, il destino dell’uomo è impregnato dal sangue, inteso sia come simbolo di vita che come simbolo di morte.
infatti nell’opera ci sono citazioni da “Il mucchio selvaggio” di Sam Peckinpah e da “Butch Cassidy” di George Roy Hill. Del primo, oltre alla sparatoria letteralmente esplosiva del capitolo “Volti”, prende una tortura di un animale: qui una tartaruga che agonizza nel cerchio (ancora…) della sofferenza e della memoria, lì degli scorpioni che mentre facevano strage di formiche vengono bruciati vivi da bambini sadici, divenuti dei pazzi e crudeli. La seconda, forse più gratuita, è la canzone fischiata in bicicletta dal protagonista che è la stessa sentita durante il corteggiamento, consapevolmente inutile di Paul Newman a Katharine Ross: in entambi i film è un momento sereno a cui però seguirà un epilogo tragico. Sembra che, basandoci anche su ciò che sappiamo di “Dust”, Manchevski abbia voluto creare nel suo paese natale una frontiera, un eastern. Non è un caso poi che entrambi i su citati western non siano delle celebrazioni della frontiera, ma rigurdino la sua fine, la sua scomparsa. In Peckinpah un epico urlo di odio contro tutto e tutti, in Hill una malinconica elegia. E questa frontiera a noi così vicina geograficamente e così lontana mentalmente, è ritratta sotto un segno barbarico e rituale. Viene alla mente il noir francese “I senza nome” di Jean Pierre Melville che in originale si chiamava “Le cercle rouge” (Il cerchio rosso): anche lì le vite sono unite in un cerchio di sangue e violenza voluto dal desino. Questo perchè, sembrano dirci quasi in coro due cineasti così irriducibilmente diversi come Manchevski e Melville, il destino dell’uomo è impregnato dal sangue, inteso sia come simbolo di vita che come simbolo di morte.
A cura di
in sala ::